Il cappellano incaricato esprime la necessità di creare dei legami tra il mondo e chi si trova nelle carceri, affinché nessuno resti indietro e si creino occasioni di crescita per tutti. L’Anno Giubilare, in tal senso, può rappresentare un’occasione da non perdere. Il 26 dicembre 2024, giorno di Santo Stefano, Papa Francesco ha aperto la Porta Santa nel carcere romano di Rebibbia, segnando un momento storico nella tradizione dei Giubilei ordinari. È stata la prima volta che, oltre alle tradizionali Porte Sante aperte nelle quattro Basiliche papali di Roma, è stata inaugurata una Porta Santa in un istituto penitenziario.
La nostra redazione ha avuto il piacere di intervistare monsignor Marco Fibbi, cappellano incaricato del carcere romano di Rebibbia.
Monsignor Fibbi, intanto grazie per aver accettato questa nostra intervista. Come ha vissuto la comunità di Rebibbia all’annuncio e quindi alla visita di Papa Francesco in occasione dell’apertura della Porta Santa per il Giubileo del 2025?
Grazie al Cefalino per l’opportunità che offre di parlare di carcere e dei suoi operatori. Le reazioni alla notizia della visita del Papa sono state da un lato quasi di incredulità, anche per le condizioni di salute di Francesco, e dall’altro di attesa per le conseguenze che questa iniziativa avrebbe potuto avere per la vita delle persone detenute. Soprattutto fra chi è al termine della pena o con pene brevi poteva aprirsi una prospettiva di ulteriore riduzione della stessa per le misure di clemenza menzionate nella bolla «Spes non confundit» (n. 10).
Qual è il significato simbolico di questa apertura della Porta Santa in un luogo come il carcere, dove spesso si percepisce un senso di esclusione e di separazione dalla società?
I significati sono molteplici e su più livelli: papa Francesco ha spalancato, all’inizio di questo anno, una porta sulla realtà degli istituti di pena e chi ci vive ed opera, per tutta la società civile; aver attraversato la porta circondato da tutte le realtà del carcere, detenuti e detenute e rappresentanti della Polizia penitenziaria, significa che si ribadisce la dignità di tutte queste persone davanti a Dio e di fronte a chi deve garantire percorsi di reinserimento sociale e recupero personale come stabilisce l’art. 27 della nostra Costituzione («Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.») Infine il significato più alto e spirituale ribadito dal Papa è di non perdere la speranza perché Dio perdona tutto, perdona sempre, e quindi c’è una possibilità davanti a Dio, per tutti.
In che modo questa visita del Papa può influenzare la spiritualità e la speranza dei detenuti? Quali sono le reazioni che ha notato tra i detenuti prima e dopo la visita del Pontefice?
Le persone presenti a Rebibbia, anche coloro che non hanno potuto partecipare direttamente alla visita e non erano presenti in chiesa, hanno vissuto con emozione la sua presenza e ascoltato con attenzione le sue parole tanto da acclamare al momento dell’uscita dalla chiesa dalle stanze e dalle aree di passeggio. Ho notato la speranza di chi è condannato alla pena dell’ergastolo; alcuni di loro svolgono il servizio di sagrestano, cioè di chi collabora con i cappellani nel mantenere i rapporti con tutti i detenuti all’interno dei reparti, avendo anche cura dei luoghi dove si celebra, le cappelle di reparto e delle celebrazioni e perciò hanno svolto il servizio liturgico durante l’apertura della porta santa. La loro speranza è che la pena dell’ergastolo vada completamente tolta dal codice penale italiano, così come è stata abolita nel 2014 dal codice penale vaticano da papa Francesco, il quale ha definito l’ergastolo «una pena di morte nascosta».
Papa Francesco ha sempre posto un accento particolare sul tema della giustizia sociale e della dignità della persona. In che modo la visita del Papa potrebbe contribuire a rafforzare il dialogo tra il carcere e la società civile, e soprattutto nella sensibilizzazione su temi come il reinserimento dei detenuti?
In questi ultimi anni, dopo le chiusure del Covid, mi pare che ci sia un interesse esplicito della società civile e soprattutto delle componenti produttive ad includere i detenuti nei processi lavorativi dentro ma soprattutto fuori dal carcere grazie ai benefici fiscali e contributivi della legge Smuraglia (Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti, LEGGE 22 giugno 2000, n. 193). Quello che ancora manca è la disponibilità ad accogliere i detenuti in misura alternativa, detenzione domiciliare, affidamento ai servizi sociali, per coloro, e sono molti, che non hanno un idoneo alloggio. Ma questo è il tema dell’abitare che è critico in molte parti d’Italia e che necessita di risposte ampie da parte dello Stato nel favorire l’edilizia popolare e dare la possibilità di affitti accessibili alle fasce della popolazione meno abbienti, tra le quali rientrano anche i detenuti ed i loro familiari.
Cosa si aspetta dal Giubileo 2025? Crede che questo evento potrà segnare un punto di svolta per la vita spirituale e sociale all’interno di Rebibbia ma in generale delle carceri italiane?
Il gesto del Papa che, con uno sforzo straordinario, si alza in piedi e bussa con veemenza alla porta santa, ha trasmesso indubbiamente ai detenuti il coraggio e la resilienza con cui poter affrontare il disagio che talvolta induce persino ad atti estremi come il tentativo di suicidio. Il Giubileo rappresenta per tutti una grande occasione di rilancio della vita spirituale e anche delle relazioni all’interno degli istituti, fra i detenuti e con le altre componenti della vita del carcere. La proposta di rinnovamento della vita spirituale e interpersonale passa però attraverso l’adesione a un modello che viene rappresentato dall’introdurre nelle dinamiche quotidiane il rispetto di tutti nella propria dignità e nelle professionalità che si esprimono all’interno delle carceri. Mi riferisco ai detenuti ma anche a chi è incaricato della sicurezza, come della salute o della formazione culturale o spirituale delle persone detenute. Solo partendo dal comune rispetto degli altri può scaturire questa svolta negli ambienti di detenzione e questa è una responsabilità condivisa da tutti coloro che ci vivono ed operano.
Quali sono i sentimenti che ha potuto scorgere nei volti di chi vive ogni giorno la realtà del carcere, non mi riferisco solo ai detenuti ma in generale tra gli agenti penitenziari, l’amministrazione e il personale tutto?
I riflessi più profondi li dobbiamo ancora evidenziare nelle prossime settimane e mesi, ma certamente è presente in tutti il desiderio di sperimentare l’incontro con la misericordia di Dio attraverso il passaggio della porta santa anche con i propri familiari, così come è stato richiesto da tanti di loro. Desiderio di attraversare la porta santa espresso anche da chi a Rebibbia ci lavora. Se la domanda è in riferimento all’attualità e all’inizio del Giubileo certamente vi sono degli indicatori promettenti. Se invece la domanda riguarda maggiormente il lungo periodo, ossia gli anni che stiamo vivendo, i segnali sono più preoccupanti, di stanchezza per non dire di esasperazione. Mi riferisco alle condizioni di vita e di lavoro all’interno delle carceri segnate non solo dal sovraffollamento ma da una percentuale di detenuti malati, con sofferenze psichiatriche e di tossicodipendenti che rendono in alcune circostanze praticamente impossibile vivere ed operare all’interno degli istituti. Su questo ancora molto va fatto al di là delle intenzioni di rendere gli spazi detentivi più adeguati e le strutture esterne come le Rems e le comunità terapeutiche realmente disponibili.
Per concludere, che messaggio vorrebbe trasmettere a chi da fuori osserva la realtà del carcere e quali sono le sue speranze?
Il mio messaggio risiede nella speranza che attraverso la riflessione e il dibattito si possano avviare dei cambiamenti in grado di unire la società civile con le persone detenute, in un percorso condiviso di crescita e reinserimento sociale che possa superare il pregiudizio nei loro confronti e qualunque forma di “giustizialismo” che non è mai rispettoso della dignità umana.
Giovanni Azzara
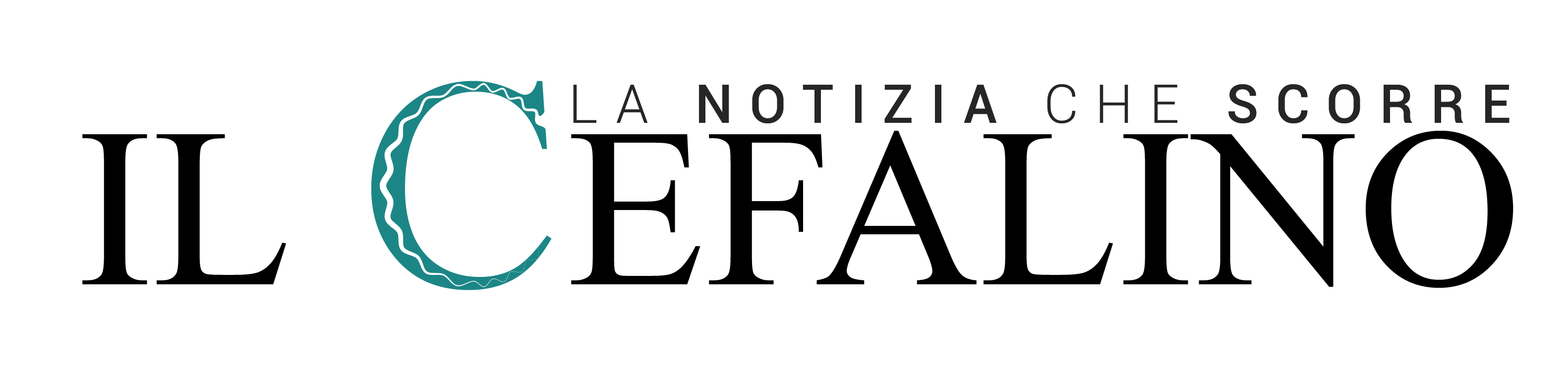











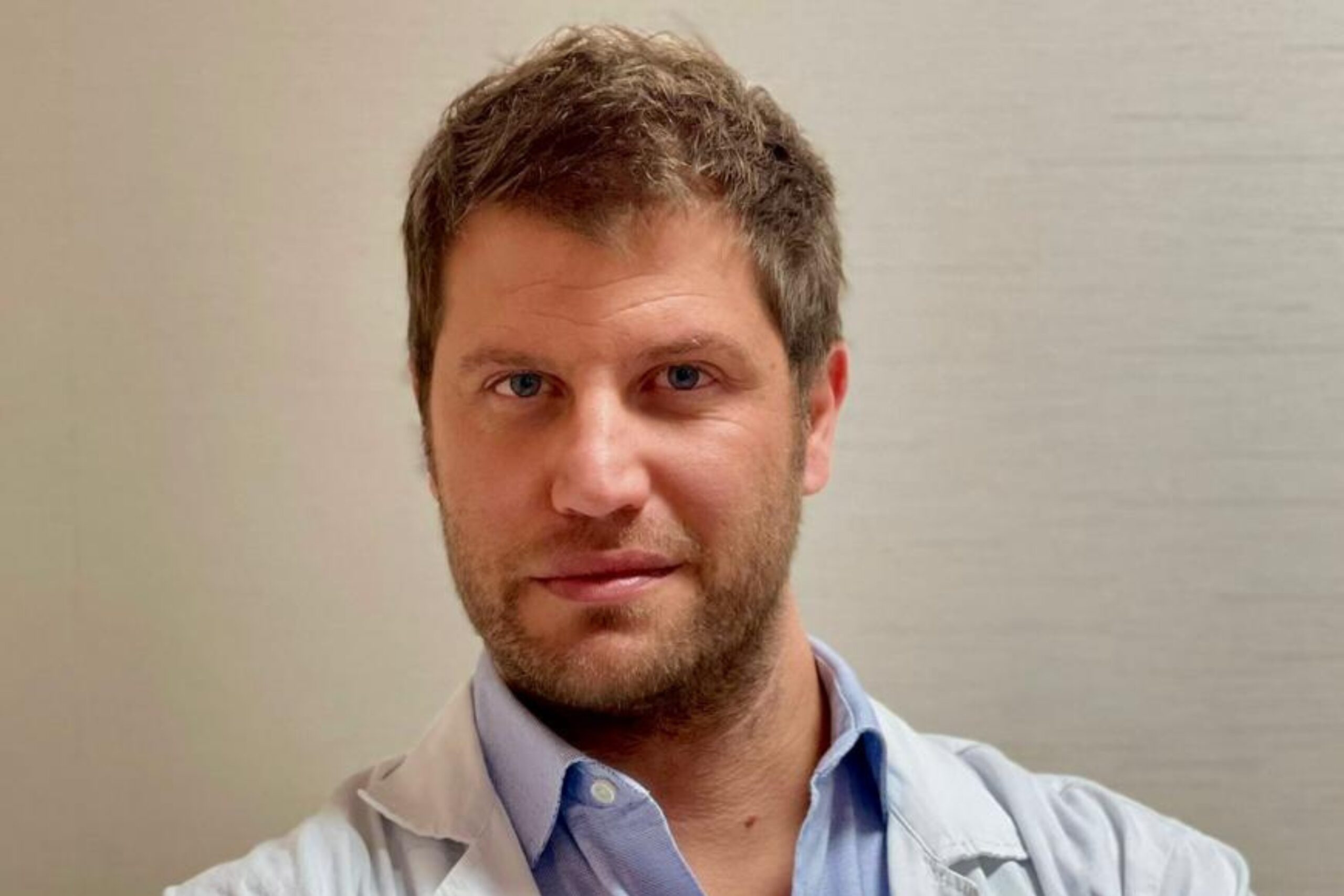


Lascia un commento