Fino a circa 50 anni fa, Caltavuturo poteva contare su una particolare usanza: i sepolcri, in dialetto “sabburca”, che venivano allestiti nelle varie chiese del paese.
Nei secoli passati la pietà cristiana ha cercato di rappresentare in diversi modi i momenti
più importanti della vita di Gesù. L’anno civile era scandito dalle solennità cristiane, la vita individuale dalla celebrazione dei sacramenti, la vita sociale e comunitaria dava spazio al “teatro sacro” con effetti straordinariamente coinvolgenti. La liturgia, isolata nella forma e nella lingua dal popolo, restava un’esperienza riservata e compresa esclusivamente dal clero. Il popolo a poco a poco elaboró “celebrazioni” proprie dentro e fuori le chiese, prima e dopo le celebrazioni liturgiche. Nel tempo, ogni comunità cristiana creò interpretazioni proprie dei misteri della salvezza, inventando forme specifiche di comprensione e di espressione dei fatti della fede in grado di assicurare la partecipazione di tutto il popolo cristiano. Se a Natale era doveroso rappresentare la grotta di Betlemme, in Quaresima non si poteva non rappresentare la passione di Cristo. Tra le rappresentazioni sacre della Settimana santa, un posto importante era occupato dal giardino del santo Sepolcro.
In alcune chiese, oltre alla rappresentazione del sepolcro, la classe artigiana rappresentava con tecniche varie i momenti salienti della passione di Gesù, o i temi evangelici delle domeniche quaresimali.
La famiglia Faulisi conserva una serie di dipinti su tela che venivano usate nella Chiesa di San Giuseppe. Essi raffigurano: l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, l’Ultima Cena, l’incontro di Gesù con le pie donne, il compianto sul Cristo morto e la deposizione di Gesu nel sepolcro. Oltre a questi dipinti, i Faulisi conservano anche degli schizzi su ampi fogli di carta che, disposti a terra, venivano coperti con sabbia colorata. I temi rappresentati sono: la Samaritana, il Battesimo di Gesù e la Discesa dalla croce. Probabilmente queste opere sono state realizzate da due fratelli: Carmelo e Giuseppe. Carmelo, pilota d’aereo morto il 13/06/1924, Giuseppe esercitava l’arte di ebanista e si dilettava anche nella pittura, morto il 7/12/1964.
Ai lati del lenzuolo o del disegno sul pavimento venivano posti rami, alberi, cespugli, arbusti ed erbe spontanee che i fedeli portavano dalla campagna, in modo da ricreare un vero e proprio giardino. Inoltre venivano messi dei tendoni (frazzata) all’entrata della chiesa per oscurare l’ambiente. Il tutto veniva adornato con fiori e candele. Era un modo per onorare Gesù Eucarestia nel grande giorno del Giovedì Santo, in cui si celebra l’istituzione dello stesso Santissimo Sacramento.
Ma per la gente era talmente forte l’idea e lo spettacolo del giardino-sepolcro che considerava quei luoghi come delle vere e proprie tombe, e le visitava in silenzio e con profondo sentimento di cordoglio.
Dobbiamo specificare, però che “sepolcro”, nonostante sia il termine in voga per eccellenza, è errato. In realtà il cristiano, oltre che a meditare sulla morte di Gesù, quindi sulla sua sofferenza e sul sangue versato per noi, durante il Giovedì Santo è propenso ad adorare l’Eucarestia come segno che Gesù è vivo e risorto.
Quando tutto era pronto, i Sepolcri venivano visitati dai paesani per ammirare le varie realizzazioni in particolar modo il Giovedì e il Venerdì Santo. Gruppi di ragazzi, di amici e di famiglie con i loro bambini vestiti da angioletti, da suore, da monaci e da preti, facevano il giro delle chiese per poterli visitare, ad esempio partendo dalla Chiesa del Collegio a salire, secondo il tradizionale percorso della processione del Venerdì Santo.
Era uso realizzare i “lauriaddi” fatti con germogli di grano o di altri semi. Le piantine vengono fatte crescere per tre/quattro settimane in un luogo completamente buio, per tutto il tempo i germogli vengono innaffiati di tanto in tanto. La crescita in assenza di luce blocca la sintesi clorofilliana delle giovani piantine, e questo spiega quindi la ragione della loro colorazione tipica bianca, simbolo di purezza e resurrezione, vengono utilizzate ancor oggi in alcune regioni del sud Italia e specialmente nelle isole per adornare quello che più propriamente viene definito come altare o “cappella” della reposizione. L’altare della reposizione, per intenderci, è quello “spazio” della Chiesa (nel nostro caso la cappella della Madonna della Balata nella Chiesa Madre) dove al termine della “Messa in Coena Domini” del Glovedi Santo, viene deposta la pisside con le specie eucaristiche consacrate fino al pomeriggio del Venerdi Santo, quando, durante la Liturgia della Passione del Signore, verranno distribuite ai fedeli per la comunione sacramentale.
Su ogni “sabburcu” vigilavano coppie di confrati del SS. Sacramento che si davano il cambio ogni due ore, per adorare il Santissimo Sacramento lì riposto e per non lasciare incustodita la Chiesa.
Anche quest’anno si è pensato di realizzare i cosiddetti “sabburca”, a cura delle Confraternite, dopo la riproposizione del 2024 dopo tanti decenni, in una maniera rivisitata, come se fossero delle rappresentazioni artistiche dei vari momenti della Passione, infatti sono stati realizzati secondo la reinterpretazione moderna. Sono stati allestiti dalla Domenica delle Palme sino alla Domenica in Albis nelle Chiese: Badia, San Ciro, Immacolata e San Giuseppe. Nei giorni del Giovedì e Venerdì Santo, ovviamente nella Chiesa Madre e nella Chiesa del Convento dove si celebrano i riti del Triduo Pasquale.
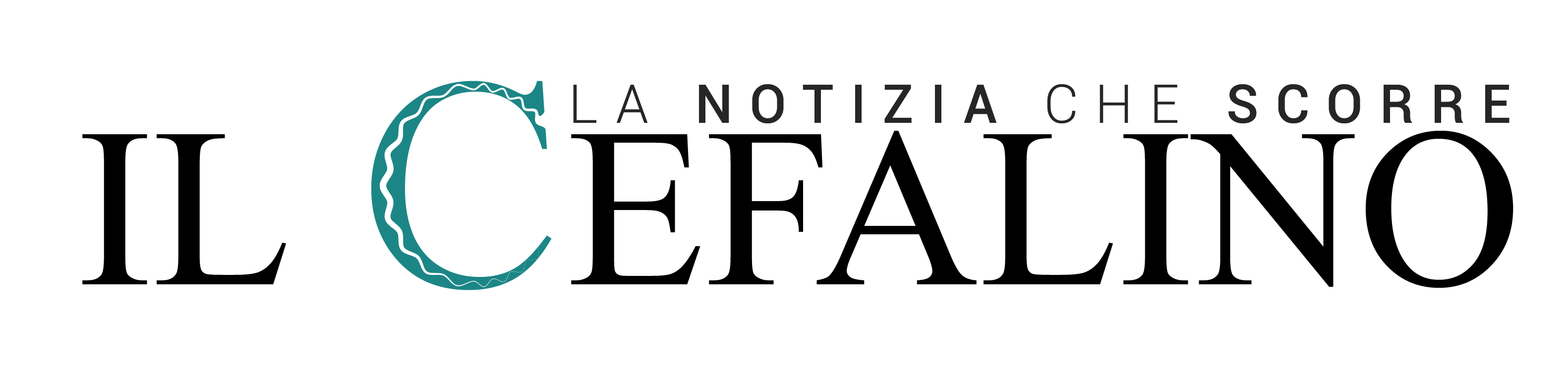













Lascia un commento